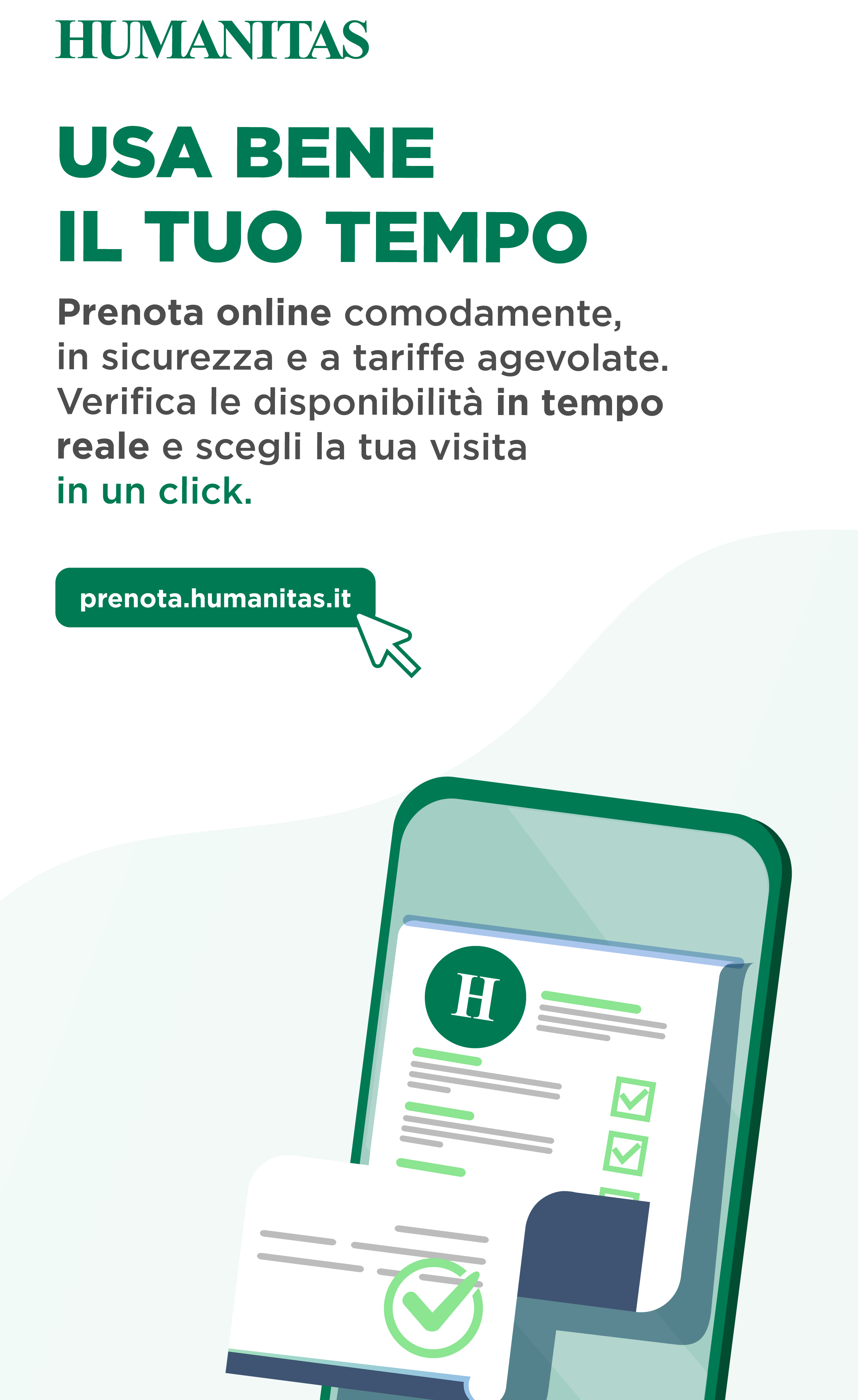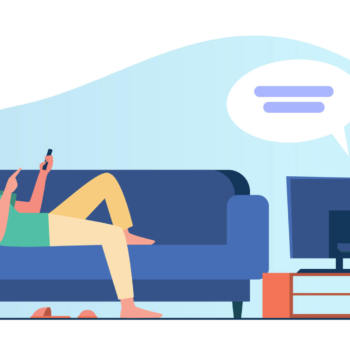Monica Inroga è un giovane medico-chirurgo originaria della Repubblica del Mozambico. Specializzanda di Chirurgia Generale dell’Università degli Studi di Milano, a novembre terminerà la sua specializzazione in chirurgia oncologica in Humanitas. La seconda laurea, dopo quella ottenuta all’ISEF per richiesta del governo mozambicano. Una vita dedicata alla medicina e alle missioni umanitarie, tra l’Italia e l’Africa.
Il suo obiettivo però è tornare nella sua terra natale, per applicare tutto quello che ha imparato qui in Europa ad una realtà difficile e bisognosa, in cui l’aspetto strettamente sanitario si lega a fenomeni sociali e culturali, dove al fianco – e spesso al posto – del medico lavorano gli stregoni.
Tanta dedizione e tanta voglia di fare si leggono negli occhi di questa ragazza africana che, con entusiasmo, ci racconta come è nata la sua passione.
Come è cominciato il tuo impegno nelle missioni dell’Africa?
“Ho scelto questa strada dopo un’esperienza che ho avuto in Monzambico, il Paese in cui sono nata. Nell’89 sono stata chiamata a fare il servizio militare insieme ad altre ragazze diciottenni. Stavo tornando da una partita di pallavolo e sono stata portata in caserma con la forza. Ho dovuto lasciare tutto: per 8 mesi sono stata addestrata alla vita militare, mi sono dovuta presentare ogni giorno ai vari dipartimenti distribuiti in città per dimostrare che ero ancora all’interno del paese. Eravamo in un regime dittatoriale, poca democrazia e molto controllo. Finita la guerra nel ’92, con l’appoggio della mia famiglia ho deciso di venire in Europa per seguire la mia passione: studiare medicina. Conoscevo un ragazzo italiano, con cui mi sono sposata e che ho raggiunto in Italia. La mia famiglia – otto fratelli più due adottivi, tutti laureati – è rimasta là. Durante il percorso universitario ho partecipato a brevi missioni, in giro per l’Africa, in Zimbawe, in Monzambico, in Angola. Ero già stata in Ghana da piccola per alcune partite di pallacanestro – sono stata campionessa juniores dell’Africa – e ci sono ritornata da volontaria. Ho cominciato così il mio impegno umanitario nelle missioni”.
Cosa cercavi quando hai deciso di portare i risultati dei tuoi studi medici nella realtà africana?
“Il nostro modo di studiare medicina ti porta poco a contatto con il paziente, è molto teorico. Io avevo la necessità, non solo di entrare in contatto con il paziente, ma anche di vivere la realtà africana. Temevo un giorno di rientrare nel mio Paese e non avere più riferimenti, di non essere in grado con le nostre poche risorse di fare diagnosi o di gestire una situazione sociosanitaria davvero difficile. Un medico in Africa non può fare solo sanità, si deve preoccupare dei suoi sviluppi sociali.
Penso alla circoncisione. Se non la fa un medico in un ambiente ospedaliero estremamente sterile, la farà uno stregone con una lametta infetta, sporca, arrugginita, utilizzando la stessa lametta per tutti i bambini. Bisogna evitare una situazione del genere, che produce non solo la trasmissione di malattie gravi, ma anche infezioni, traumi, amputazioni psicologicamente non accettabili. Un medico deve entrare a fare parte di questo microcosmo, in cui la società e la medicina camminano insieme. Io temevo che sarei stata fuori da questo, vivendo in Italia, in un ambiente protetto, dove tutto è pulito, bello e preciso. In Mozambico invece ho conosciuto un geologo italiano, che faceva il servizio civile in una missione. Così mi sono avvicinata per la prima volta al mondo del no profit.
Sono stata in Africa con varie onlus, ma penso che sia meglio fermarsi a lavorare con una sola associazione, perché così si concentrano le energie, le risorse umane ed economiche. Nelle mie varie esperienze ho trovato tanta umiltà e molto spirito di sacrificio. Si è volontari nel vero senso della parola: non siamo pagati, anzi il viaggio e le varie spese – tranne vitto e alloggio – sono pagati da noi. Sacrifichiamo la nostra economia per andare a fare vero volontariato”.
Che esperienze hai fatto? Dove sei stata?
“Nel ’94 sono stata in Angola, in un ospedale pediatrico. Tutti gli anni vado almeno tre volte in Monzambico, dove faccio parte del dipartimento di chirurgia dell’ospedale di Quelimane, dove sono nata. Lì c’è un missionario cappuccino, un chirurgo, Aldo Marchesini, a cui devo la mia vocazione. Fin da piccola ho voluto seguire il suo modello. Lui mi diceva: “Tu mi sostituirai!”. Mi chiamava sempre “la mia sostituta”. Appena posso vado a dargli una mano. Aiuto in ospedale e nell’orfanotrofio della mia città. Ci sono 100 bambini abbandonati: sono malnutriti ed hanno problemi di malattie infettive… Sono stata in Zimbawe, ed ora sono in partenza per il Ghana con una nuova missione con l’obiettivo di rinnovare un vecchio ospedale”.
Tra tutte queste esperienze, c’è un episodio che ricordi in modo particolare?
“Tantissimi! Ma uno in particolare lo porto ancora dentro. Ero in Mozambico per il tirocinio pratico chirurgico. Al pronto soccorso è arrivato un bambino con gravi ustioni di terzo grado sul 50% del corpo. Per 49 giorni ha lottato con una forza d’animo incredibile, senza mai lamentarsi, e noi medici abbiamo lottato con lui, provando tutte le terapie possibili. Purtroppo è morto di disfunzione multiorganica. Ma ricorderò per sempre lo sguardo generoso e riconoscente con cui ci ha guardato suo padre anche dopo la morte. Un’altra persona avrebbe urlato dal dolore, ci avrebbe insultato; lui no, ci ha ringraziato per tutto quello che avevamo fatto. La mia tesi di studio quell’anno ha riguardato proprio quella storia. Porto ancora dentro lo sguardo di quel padre che ha perso il suo unico figlio. Questo paga dello sforzo. Ed ora quell’uomo lavora con noi, fianco a fianco, all’ospedale di Quelimane. Questo è ciò che colpisce quando decidi di dedicare la tua vita a un’esperienza del genere: lo sguardo dei bambini, lo sguardo degli anziani, delle persone malate che anche quando sanno che non c’è altro da fare ti guardano comunque riconoscenti”.
E il tuo futuro dov’è?
“In Africa. L’Africa è rimasta ancora molto povera, ha bisogno di infrastrutture e di risorse umane. Ci sono grandi sfide, come il flagello dell’Aids. Se le persone sane non tornano in Africa ad aiutare quelle malate, non potrà esserci futuro. I bambini devono avere un’istruzione, devono poter accedere a servizi qualificati. Noi che abbiamo studiato in Europa, in America, in Australia possiamo farlo. Ma solo se torniamo. Da lontano non si fa nulla. Esiste un proverbio africano: se tu sei lontano il tuo bestiame muore. Muore non perché non abbia la possibilità di mangiare, ma perché soffre della tua mancanza. Da lontano non si fa niente. Bisogna andare sul posto. Concretamente”.
Di Laura Capardoni